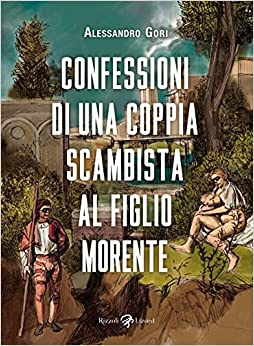La voce dei cretini si sentiva di meno, era più flebile, in età pre-digitale: chi è abbastanza vecchio se lo ricorda. Non che non ci fossero, naturalmente, i cretini: ma erano cretini noti, familiari, che s’incontravano a scuola, in ufficio o a casa, e che con un po’ di attenzione si riusciva anche a non incontrare. Voci singole, individuate, non un coro, e voci che nella sfera pubblica faticavano a trovare ascolto, perché per accedere alla sfera pubblica esisteva una soglia che non era facile attraversare. Adesso la voce dei cretini si sente dappertutto, è una valanga che rovina le giornate, guasta l’umore, rincretinisce a propria volta soprattutto se uno non fa filtro, ripulendo ogni tanto la lista dei propri contatti, o scartando quasi tutto ciò che sui social network è scritto in italiano. Le conseguenze sociologiche e psicologiche di questa prevalenza del cretino sono state descritte così tante volte da diventare un cliché: essa zittisce gli intelligenti, pieni di dubbi, e galvanizza gli stupidi, pieni di certezze; portando il dibattito all’ipertrofia lo rende impossibile o inutile; vanifica le mediazioni; e nei non-cretini genera un senso di incredulità, poi di rabbia, poi di prostrazione… Tutte cose arcinote. Ma come suona la voce dei cretini? Come si esprimono questi eroi del nostro tempo?
Fino a qualche tempo fa, captare le loro voci significava mettersi in ascolto dentro la realtà, nei luoghi di lavoro o di studio, nelle strade, e trasportare quel precipitato d’esperienza sulla pagina o sullo schermo: il linguaggio da patetico aspirante capitano d’industria di Sordi nel Vedovo, le pantomime del dannunziano marchese Stucchi, i modi spicci e volgari del self-made man Fenoglio. Ma dato che la realtà è stata esautorata prima dalla televisione e poi dalla rete, ora il punto d’osservazione dev’essere interno a questi media, perché è lì che si collaudano e si propagano i nuovi modi di parlare, cioè di pensare. Per esplorare il nuovo mondo delle TV private, negli anni Ottanta Tommaso Labranca passava ore davanti alla TV prendendo appunti, e quando non poteva guardarla la registrava su batterie di cassette VHS. Quarant’anni dopo, Alessandro Gori (alias Lo Sgargabonzi), che per certi versi è il suo erede, fa una dieta simile, salvo che il posto della TV, nella sua vita come in quella di tutti, l’ha preso internet (non è un caso che i suoi pezzi comici siano nati una decina d’anni fa sulla sua pagina Facebook, e poi siano evoluti in racconti che vivono al di fuori della rete); soprattutto da internet, dunque, deduce il suo campionario di casi umani.
Quattro anni dopo la precedente raccolta Jocelyn uccide ancora, questo nuovo libro è così per prima cosa un geniale esercizio di mimesi. Gori ascolta o legge le parole degli altri, dopodiché le rifà al pantografo enfatizzando i tic, i cliché, le miserie verbali che intasano il discorso corrente. «Allora io voglio dire una cosa», così inizia Sarracenia Leucophylla, il monologo nel quale la passivo-aggressiva Miranda racconta del suo amore per Aldo, che ha il torto di essere sposato ma soprattutto commette la leggerezza di farsi venire un tumore al cervello, e deve quindi interrompere la relazione. Ma Miranda non è d’accordo: «Sì, bando al fair play, ormai che c’ero volevo diventare la titolare anche perché me lo meritavo. Del resto Miranda, che sarei io, per quarant’anni ha messo sempre chiunque davanti a se stessa e ora sta lentissimamente iniziando a volere un pochino di bene sapete a chi? A Miranda. Questo me lo sono detta davanti allo specchio del bagno di Eataly durante una serata degustativa finita in lacrime, con la gente intorno che mentre si asciugava le mani col phon a parete mi dava ragione». La volgarità delle parole («la titolare», la «serata degustativa»), delle frasi fatte («bando al fair play»), del parlare di sé in terza persona, l’egolatria camuffata da modestia («… volere un pochino di bene sapete a chi?») – non è questa una perfetta rappresentante della nostra Era dell’entitlement? (in più, Gori è un asso negli effetti di realtà: il phon a parete). Oppure, Balocchi e profumi, sfogo di un’adolescente inquieta su Facebook durante un pranzo di Natale in compagnia di parenti chiaramente non all’altezza: «Regà, veramente, aboliamo sto Natale demmerda in casa de nonna della serie #nseponnovede. Non ne posso più. Sono trincerata in un pranzo (demmerda) coi familiari, e vi dico, fateme un favore, chiamate Marco Cappato […] Non sanno un cazzo de noi giovani e non gliene frega un cazzo de capì, non sanno del poliamore, del no strings attached […]. Morti siete, morti! Noi nel 78 rapivamo Moro». Si vive in posa, si recita, si parla non per comunicare ma per mostrarsi, posizionarsi, darla a bere, ignari di qualsiasi cosa stia oltre i confini del proprio io miserabile: «So che quello che mi accingo a sostenere scatenerà un vespaio, ma me ne assumo ogni responsabilità: Stanley Kubrick è un grandissimo regista». A un certo punto, a tanto è giunta la confusione delle lingue, rispunta fuori persino un paninaro degli anni Ottanta, tipo ultimo kamikaze nelle foreste giapponesi: «Hello galli! Vi rullo sul papiro per mettervi in guardia a tutti quanti, dai burghini ai geronti…».
Ho detto che il libro di Gori è per prima cosa un esercizio di mimesi; ma non solo, perché accanto a questo effetto comico che si genera dal linguaggio c’è un effetto comico che si genera dalle situazioni. Gori ha la fantasia del favolista, però contaminata da tutte le parole, gli oggetti, i marchi, i personaggi che ci riempiono l’esistenza da quando la distanza tra noi e il mondo si è prima accorciata, con la TV, e poi azzerata con la rete. Così la storia d’amore tra il principe e la principessa diventa, chissà per quali folli cortocircuiti mentali, quella tra il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e la leader delle Scissor Sisters Ana Matronic: «Gentile signorina Ana, l’ho scoperta qualche giorno fa. Stavo ascoltando su YouTube le canzoni del mio gruppo preferito, i Barclay James Harvest, intanto che organizzavo degli scartafacci (il nostro lavoro è anche tanta, troppa burocrazia)». Parte uno scambio di e-mail e messaggini di una dozzina di pagine al termine del quale non guarderete più con gli stessi occhi l’ottimo – direbbe Gori – Presidente del Consiglio superiore di sanità (che è poi l’obiettivo di quasi tutti i racconti del libro: la costruzione di una surrealtà in cui il confine tra vero e immaginario si annulla, e le cose e le persone evaporano, diventano puri nomi, da mescolare come un mazzo di carte). Sotto, corre una vena d’angoscia che dà risultati a volte spettacolari (il pezzo nostalgico sul fallimento dei gelati Eldorado), a volte ottimi (il pezzo sulla morte Veleno per topi: «E se mi dicevano che l’Aldilà non esisteva, io avrei pensato che da lì a che ero vecchio si sarebbero organizzati per costruirlo da qua. Non avrebbero più permesso che si sparisse così. Mi sarei aggrappato alla manica di mio babbo e gli avrei chiesto se la Banca Popolare dell’Etruria avrebbe potuto fare qualcosa»), a volte così così (Letti, il pezzo che, ahimè, chiude il libro). Ma nell’insieme, non solo il migliore scrittore comico italiano (a questo livello forse solo certe pagine dello Sbiancamento dell’anima di Rocco Tanica), ma uno dei più dotati e originali scrittori in circolazione.
Alessandro Gori, Confessioni di una coppia scambista al figlio morente, Rizzoli 2022, euro 16, pp. 205.