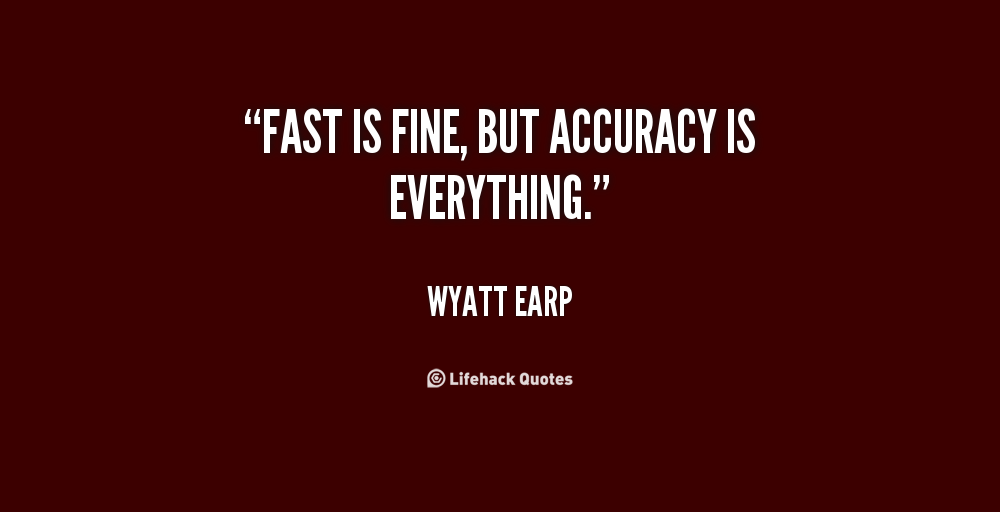«La filologia italiana sta bene. È ben insediata nell’insegnamento universitario, anche con varie dizioni più specifiche; ha riviste e cultori in buon numero; collane ancora attive, malgrado i tempi grami; incontri e congressi anche». Così cominciava una splendida recensione di Guglielmo Gorni agli Atti del congresso di Lecce del 1984 su La critica del testo («Rivista di letteratura italiana», IV 2, 1986). Trent’anni dopo, la filologia italiana – intesa come filologia su testi italiani – sembra essere ancora in ottima forma: continuano a uscire studi ed edizioni eccellenti, e più in generale resta viva, anche tra gli studiosi italiani che non professano la filologia, una sensibilità per la materialità dei testi e per la loro tradizione che non ha eguali nelle altre nazioni europee.
Se però allarghiamo la visuale, e riflettiamo sul posto che gli studi filologici occupano nel panorama attuale degli studi umanistici, ecco che l’ottimismo s’incrina, e il confronto col passato anche recente costringe a riflettere sul fatto che alla buona salute interna, per così dire, cioè al buon funzionamento della macchina degli studi filologici, possa non corrispondere una altrettanto buona performance ‘nel contesto’: perché sembra essersi allentato il nesso, un tempo molto stretto, tra filologia e critica (vale a dire che non è più prevalentemente nel novero dei bravi filologi che maturano i bravi critici: ma c’è stato un tempo in cui non faceva sorridere la dichiarazione di Avalle secondo cui per «prepararsi all’attività di critico letterario … non c’è niente di meglio che lavorare sulla tradizione manoscritta di un testo antico, possibilmente ricca di testimoni e per di più ‘contaminata’, e di non fare altro per un congruo numero di anni»); perché è raro riuscire a udire la voce dei filologi in questioni culturali che non siano mere questioni di dettaglio; perché anche nelle università gli insegnamenti di filologia perdono terreno rispetto ad altri insegnamenti diciamo più intonati allo spirito dei tempi; e perché non di filologi ‘all’italiana’ sembrano affamati i dipartimenti di humanities stranieri: ma semmai di comparatisti, esperti di cinema, di cultural studies.
Ai fedeli alla causa della filologia (quorum ego) fa dunque piacere leggere volumi come Questioni filologiche: la critica testuale attraverso i secoli, che raccoglie i contributi presentati a un congresso tenutosi tre anni fa al dipartimento di Italian Studies dell’Università di Toronto. La call for papers del congresso citava, come motto, un’osservazione di Varvaro («quasi non si vince una cattedra universitaria di filologia romanza o di letteratura italiana se non si è fatta un’edizione critica»: ma Varvaro avrà inteso dire «filologia italiana», non «letteratura»); e fissava, per i contributi, obiettivi ambiziosi, invitando a rispondere a quesiti come «Fino a che punto la filologia può supportare [sic] l’interpretazione e/o la traduzione di un testo? La filologia può fornire una piattaforma scientifica sulla quale tutte le discipline umanistiche siano in grado di interagire? È possibile produrre saggi critici accurati di un testo letterario anche se l’interpretazione non si basa sulla sua definitiva ricostruzione?». Quesiti che riaffiorano, con risposte intelligenti, nelle pagine dei vari saggi, ma per fortuna solo incidentalmente, in margine all’esame di casi concreti: la metafilologia è noiosissima.
Più d’uno, tra gli autori dei contributi al volume, prende atto del fatto che l’aria del tempo è cambiata, e dichiara i suoi obiettivi con modestia. Filologia sì, ma non troppa è il titolo del keynote speech di Paolo Cherchi, che – in linea con un paio di interventi recenti di Francesco Bausi – auspica la realizzazione di «buone edizioni affidabili e di servizio», cioè anche non condotte sull’intero testimoniale, e quindi a rigore non critiche, ma ben tradotte e ben commentate, sul modello di quelle della collana I Tatti Renaissance Library: «A volte conviene abbassare le aspettative e puntare su un’edizione ‘plausibile’ (ad esempio «secondo l’antica vulgata» della Commedia, come ha fatto il Petrocchi) anziché arenarsi in progetti di edizioni irrealizzabili. A volte si può giustificare l’edizione basata su una famiglia di manoscritti anziché risalire fino all’idea di collocare tale famiglia nella storia di una tradizione testuale pressoché impossibile da ricostruire con certezza» (salvo naturalmente che la scelta della «famiglia di manoscritti» sulla quale basarsi per l’edizione presuppone la recensio, dunque un’operazione filologica non parziale: il che nulla toglie alla ragionevolezza delle osservazioni di Cherchi). E Neil Harris, in un contributo che è anche un’eccellente esposizione del metodo tipofilologico, spiega che «un bravo filologo ha molto in comune con un netturbino, dato che il principale obiettivo di entrambi è tenere in ordine il proprio sistema» (e dato che il «sistema» di Harris è, in questo caso, I promessi sposi di Manzoni, nessun esercizio di pulizia, cioè di migliore comprensione della storia del testo, può dirsi superfluo).
Tanto understatement si rispecchia anche nella scelta degli argomenti: più autori minori (anche minimi) che classici, più resoconti intorno a esperienze di lavoro che scritti programmatici o contributi di sintesi. E non ci sarebbe che da elogiare questa empiria, se la premessa al volume non avesse appunto fatto balenare orizzonti più ampi. Ma, dimenticando la premessa, si leggono con molto interesse i tre saggi di più ampio respiro che aprono il volume, cioè quelli di Cherchi, Harris e Procaccioli (sul problema della grafia nell’edizione critica di opere autografe o sorvegliate dall’autore), e s’impara parecchio dagli interventi più circoscritti degli altri contributori, interventi che testimoniano anche l’ampiezza di spettro degli studi filologici ben intesi: dalla circolazione dei testi (Mainini sulle tracce dei testi volgari negli antichi inventari; Bertolio sulla fortuna del De interpretatione recta di Leonardo Bruni) allo studio delle macrovarianti (Zorzi Pugliese sul Cortegiano), dalla morfologia del libro di poesie (Comiati su Celio Magno) al riscatto dall’oblio di uno dei tanti minori che scrivono versi nell’Italia del primo Seicento (Bazzichetto su Ridolfo Campeggi). Nell’ultimo terzo del volume si leggono contributi sul Novecento (Ungaretti, Marinetti, Wittgenstein, Pessoa, Saba, Montale, Pomilio); e qui per la verità un po’ di dubbi vengono, un po’ per qualche flirt non davvero necessario con la teoria letteraria (proprio non vedo come Opera aperta di Eco possa aiutare a orientarsi negli archivi di Wittgenstein e Pessoa), un po’ per il rischio di adoperare le varianti d’autore, che nel Novecento fioccano, come in catena di montaggio: usare la critica delle varianti ogni tanto, per illuminare un dettaglio, va benissimo; usarla in serie, per costruire un sistema, va meno bene (almeno per il lettore, che si annoia mortalmente).
Nel volume manca – se l’obiettivo era quello di riflettere criticamente sul senso della filologia oggi, e sui suoi possibili usi – la voce di un non filologo, o anche di un anti-filologo, cioè di qualcuno che, con meditati argomenti, difenda la tesi (non mia, ma non assurda) che studi come questi hanno fatto il loro tempo, e che a cose come le didascalie delle Rime di Celio Magno o le microvarianti di Ungaretti non serve prestare molta attenzione. E manca un indice dei nomi (al suo posto, sesquipedali Biographies of the Contributors).
Questioni filologiche: la critica testuale attraverso i secoli, a cura di Pamela Arancibia, Johnny L. Bertolio, Joanne Granata, Erika Papagni, Matteo Ugolini, Firenze, Franco Cesati Editore, 24 euro.