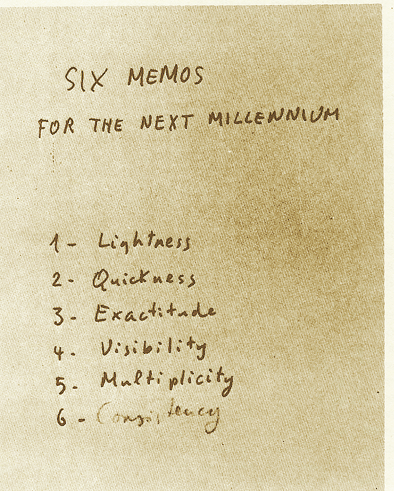Ho sempre pensato che le Lezioni americane di Calvino siano un brutto libro, e qualche anno fa la rivista «Belfagor» mi ha dato una quindicina di pagine per argomentare questa opinione: opinione che credevo largamente condivisa e che ho scoperto invece, con una certa sorpresa, essere minoritaria, se non addirittura originale. L’articolo si può leggere anche qui. A quel saggio ha mosso ora alcune obiezioni Mario Barenghi, perciò torno sull’argomento per chiarire meglio il mio punto di vista, premettendo che ciò che mi premeva e preme, più che criticare le Lezioni americane, è criticare il tipo di discorso sulla letteratura che, a mio avviso, le Lezioni americane hanno, se non veramente ispirato, contribuito ad assecondare. Posto questo obiettivo più ampio, spero che queste note possano interessare anche a lettori che non si occupano di Calvino o di critica letteraria in senso stretto.
Seguirò passo passo l’argomentazione di Barenghi:
La prima considerazione che io vorrei fare […] è che ci sono valutazioni di gusto sulle quali è difficile controbattere: ad esempio, quando Giunta bolla come «puerile» l’uso che Calvino fa di due motti di Hoffmansthal e Wittgenstein. Ciò premesso, il capo d’accusa più consistente mi pare il primo che il saggio avanza. Quando in Leggerezza Calvino parla della novella del Decameron, a un certo punto effettivamente sovrappone all’immagine di Guido Cavalcanti fornita dal Decameron l’interpretazione «averroista» proposta da Maria Corti. Nulla da obiettare. Non c’è dubbio che nella novella del Boccaccio l’arguzia non intendesse comprendere un risvolto filosofico così sottile (e del resto non scontato); qui Calvino avrebbe dovuto aggiungere due righe di precisazione. Aggiungo però che, per correttezza, sarebbe stato questo il punto dove ricordare che le Lezioni americane che noi leggiamo non sono un testo pronto per la stampa, bensì una stesura da tradurre in inglese per una lettura pubblica (cosa che Giunta fa solo alla fine della requisitoria).
Qui conviene distinguere. Io non ho niente contro le citazioni da Hoffmansthal o da Wittgenstein. Ho qualcosa contro il citazionismo scriteriato che ha invaso, da alcuni decenni a questa parte, la critica soprattutto accademica (in ciò, soprattutto, la sua puerilità: è un vezzo, dettato dall’insicurezza, che è tipico di laureandi e dottorandi), una tendenza alla quale mi pare che le Lezioni americane di Calvino – con i loro novanta scrittori citati in centoquattro pagine, con le loro insensate giaculatorie di Valéry Parmenide Descartes Kant Musil Barthes, o di Dante Cavalcanti Valéry Dickinson James Cervantes tutti stipati in una pagina – abbiano dato un autorevole avallo. Ho qualcosa contro le citazioni adoperate come scorciatoie, come surrogati dell’argomentazione: che è appunto il caso, a mio avviso, di quegli aforismi prelevati da Hoffmansthal e da Wittgenstein.
Quanto alla novella del Decameron, «due righe di precisazione» da parte di Calvino non avrebbero cambiato niente. Perché Calvino accoglie, di quella novella, l’interpretazione più arzigogolata e seducente, quella che, mettendo da parte la lettera del testo, permette di mobilitare, fumosamente, più ‘cultura’ (l’epicureismo, l’averroismo, l’intelletto universale), e di slanciarsi con più libertà nei territori del simbolo (il «poeta-filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo»). Le due righe di precisazione avrebbero dovuto contenere l’ammissione che – come Barenghi riconosce – quella interpretazione era arbitraria. Dunque non era questo il punto in cui avvertire il lettore disattento che «le Lezioni americane che noi leggiamo non sono un testo pronto per la stampa», perché non si tratta di un’inesattezza indotta dalla fretta ma di un errore nell’inquadramento del problema. Ma quest’avvertenza va data: e io la do, infatti, non – come scrive Barenghi – «alla fine» del mio saggio (che non chiamerei «requisitoria», come non parlerei di «capi d’accusa») ma ben prima della metà: «È sempre giusto ricordare che le Lezioni americane sono degli appunti, non un libro: è molto probabile che Calvino sarebbe tornato sopra passaggi così fumosi e, francamente, mal scritti […]. Questo va ripetuto soprattutto contro l’eccesso di zelo dei suoi apologeti». Perché mi pareva e mi pare che siano loro, gli apologeti, a dimenticare spesso questo semplice fatto: che «il capolavoro sul quale Calvino è morto» (E. Scalfari), l’indagine «che si pone a livello mondiale – a livello mondiale sia per la vastità e la ricchezza delle letture, sia per l’ampiezza della proposta – sui destini della lettura e della letteratura» (A. Asor Rosa) era un insieme di ben ordinati ma parziali appunti stesi in vista di un ciclo di conferenze, non un libro.
Prosegue Barenghi:
Tutto il resto mi pare alquanto più opinabile. A proposito dell’accostamento tra il verso del sonetto cavalcantiano Biltà di donna («e bianca neve scender senza venti») e Inf. XIV 30 («come di neve in alpe sanza vento») Giunta sostiene che il confronto è fuorviante se non si dice che quello della neve è un topos, e sui topoi «è improprio fondare confronti intertestuali diretti». A me pare che il dato primario sia la corrispondenza metrico-ritmica; e poi si parla di Dante e Guido, non di due autori lontani nel tempo o nello spazio. Quanto alla «spropositata conseguenza» che Calvino ricava dall’accostamento – l’esistenza di due linee nella poesia europea, la linea della leggerezza e quella delle cose concrete – si tratta di un binomio che potrà essere giudicato più o meno utile, ma in sé non è diverso da quelle grandi opposizioni ai quali i saggisti a volte ricorrono (anche Contini, anche Auerbach).
L’accostamento tra il verso di Cavalcanti e quello di Dante è del tutto legittimo, e presente da tempo nei commenti. Ma la pagina che Calvino dedica al confronto tra questi due versi è fuorviante: (1) perché tratta come intertestuale un rapporto che è più probabilmente interdiscorsivo (un duecentista minore, Francesco Smera, nella canzone Per gran soverchio scrive un verso quasi uguale: «veder fioccar la neve senza venti»); (2) perché ignora il genere letterario al quale appartiene il sonetto di Cavalcanti, genere che si può chiamare plazer o Priameldichtung, ma che ha insomma dei tratti formali ricorrenti, tratti che vanno riconosciuti per evitare di attribuire al sonetto di Cavalcanti un’originalità di stile e di visione che esso non possiede («In Cavalcanti – scrive Calvino – la congiunzione e mette la neve sullo stesso piano delle altre visioni che la precedono e la seguono»: ma questa è precisamente la norma della Priameldicthung); (3) perché specula su differenze minuscole (davvero non si capisce come si possa dire che i due versi e bianca neve scender senza venti e come di neve in alpe sanza vento «esprimono due concezioni completamente diverse») per ricavarne (4) quelle che ho chiamato appunto conseguenze spropositate circa le «due vocazioni opposte [che] si contendono il campo della letteratura attraverso i secoli», l’una mirante a rappresentare attraverso le parole la leggerezza («una nube, o meglio un pulviscolo sottile, o meglio ancora […] un campo d’impulsi magnetici»), l’altra il peso delle cose concrete, l’una che s’ispira a Cavalcanti l’altra a Dante: «binomio» che si può certamente giudicare, come scrive Barenghi, «più o meno utile» sino a quando resta una brillante astrazione, ma che non merita di essere preso seriamente in considerazione quando pretende di trovare la sua radice storica in due versi due-trecenteschi interpretati capziosamente, cioè quando da trouvaille decorativa prova a convertirsi in giudizio storiografico. E davvero resisterei alla tentazione di paragonare questi azzardi di Calvino alle «grandi opposizioni» di Auerbach o di Contini: anch’esse tutt’altro che al riparo dalle critiche, ma di spessore troppo più grande.
Prosegue Barenghi:
Poi Giunta prende di mira l’indugio di Calvino sulla predilezione cavalcantiana per gli «spiriti», nozione e termine «del tutto usuali nella fisiologia tardo-antica e medievale, non più idiosincratici di quanto sarebbero, oggi, i termini plasma o sinapsi». Qui sbigottisco. La parola spirito ha uno spessore semantico e una ricchezza di connotazioni (oltre che una frequenza d’uso) imparagonabile a plasma o sinapsi; se così non fosse, nessuno leggerebbe più Cavalcanti da secoli – anzi, nessuno leggerebbe più poesia. Insomma: il rigore filologico va bene, ma non andrebbe usato come un diserbante.
Lo sbigottimento è fuori luogo. Intanto, sarà bene prendere atto del fatto che oggi nessuno legge Cavalcanti. Cavalcanti esiste ancora, nella memoria degli italiani che hanno fatto il liceo, perché due o tre sue poesie si trovano nelle antologie scolastiche. Se abolissimo la storia letteraria a scuola, Cavalcanti scomparirebbe dai radar. Ma proprio perché Cavalcanti esiste in quanto esiste a scuola, chi ne parla dovrebbe avere a cuore il rispetto della semantica storica, ovvero, detto più semplicemente, dovrebbe evitare di dare alle parole adoperate in un testo significati ai quali l’autore di quel testo non aveva pensato. Gli spiriti, nell’accezione in cui Cavalcanti adopera questa parola, non sono, molto semplicemente, ciò che Calvino dice che sono nelle prime pagine delle Lezioni americane, «impulsi o messaggi immateriali» (secondo la fisiologia antica gli spiriti sono infatti sostanze materiali che si propagano nell’organismo rendendo possibili le varie funzioni vitali); e non sono, come leggendo Calvino si è portati a credere, un’invenzione di Cavalcanti, il corollario alla sua propensione alla ‘leggerezza’. E bisognerebbe essere severi coll’interprete o col commentatore che, anziché segnare la distanza che separa lo spirito in accezione medico-fisiologica dallo spirito in accezione cristiana, speculasse – come Barenghi invita a fare – sullo «spessore semantico» e sulla «ricchezza di connotazioni» che questa parola evoca nella mente del lettore moderno (lo spirito come soffio vitale, essenza, anima). La lettura corretta di un verso, o di una parola, specie se questo verso o questa parola appartengono a testi di sette secoli fa, non è quella che si perde nella selva delle connotazioni, ma quella che contribuisce a sfrondarla: sicché non si tratta di «rigore filologico» adoperato come diserbante, ma di rispetto per ciò che il poeta ha voluto dire.
Dopo queste osservazioni puntuali, Barenghi fa una riserva di carattere generale sul «genere testuale» delle Lezioni americane, genere che io avrei frainteso. Le «Norton Lectures» che Calvino avrebbe dovuto pronunciare non sono un saggio, dunque – sostiene Barenghi – è pretestuoso paragonarle ai «libri di Momigliano o di Vernant»:
Calvino non è un antichista e non si comporta come tale […]. L’errore che commette Giunta riguarda l’identificazione del genere testuale al quale appartengono le Lezioni americane: la natura, la ragion d’essere del testo, le sue motivazioni; e così lo passa al vaglio di un’idea di esattezza filologica alla luce della quale dovremmo buttare a mare qualunque saggio di Bachtin o di T.S. Eliot. Il punto è che nelle Norton Lectures i relatori sono chiamati a parlare di sé, della propria esperienza creativa (si tratta di poetry lectures), non di contribuire all’esegesi degli autori che citano. Gli accostamenti che tanto infastidiscono Giunta rientrano nell’esperienza normale della lettura, e questo è quanto Calvino con ogni evidenza fa: oltre che ragionare sulla sua opera, dà conto delle proprie letture […]: in fondo il Norton Lecturer potrebbe essere uno dei lettori della biblioteca che dicono la loro nel cap. XI di Se una notte d’inverno.
Io in realtà mi guardavo e mi guardo bene dal chiedere alle Lezioni americane quello che chiedo ai saggi di Momigliano o di Vernant. Chiedo però anche all’autore delle Lezioni americane – nel momento in cui da non specialista, con pieno diritto, si mette a parlare del mondo classico – di dire delle cose sensate e interessanti, e di non indulgere alla chiacchiera a ruota libera, come accade per esempio nelle righe seguenti, che sono un miscuglio di clichés manualistici e vaghezze: «Mercurio, con le ali ai piedi, leggero e aereo, abile e agile e adattabile e disinvolto, stabilisce le relazioni degli dèi tra loro e quelle tra gli dèi e gli uomini, tra le leggi universali e i casi individuali, tra le forze della natura e le forme della cultura, tra tutti gli oggetti del mondo e tra tutti i soggetti pensanti». E gli chiedo anche di non usare la mitologia classica per dare un’aria solenne a ovvietà che potrebbero essere espresse in maniera molto più semplice e diretta (esempi nel mio saggio): è un brutto modo di usare la cultura. Io non obietto che queste ‘esperienze di lettura’ non sono utili come i Contributi alla storia degli studi classici di Momigliano; obietto che sono mediocri anche come esperienze di lettura.
Dato però che, allo scopo di dare un contesto a queste esperienze di lettura, a questo disimpegnato ‘dire la propria’, Barenghi evoca prima Auerbach e Contini, ora Bachtin e Eliot (col che torno a non capire bene quale sia, alla fine, il «genere testuale» nel quale ricadono le Lezioni americane: le poetry lectures o la saggistica accademica?), conviene forse fare qualche ulteriore precisazione.
In linea di principio, non si tratta, per usare l’espressione di Barenghi, di «buttare a mare» alcunché. Si tratta di discutere le opinioni di Calvino, Auerbach, Contini, Bachtin o Eliot con lo stesso rigore con cui si discuterebbero le opinioni del più ignoto dei ricercatori. Il nome di ‘grande critico’ o di ‘grande scrittore’ non dà diritto ad alcuna franchigia, il che significa che se – poniamo – l’interpretazione figurale della Commedia data da Auerbach non mi convince, il mio dovere di lettore non consiste né nel «buttare a mare» Figura né nell’accoglierlo in blocco per quel naturale ossequio che si nutre per le cose che abbiamo imparato sui banchi di scuola o dell’università: si tratta, appunto, di distinguere ciò che è convincente da ciò che non lo è.
In linea di fatto, non so quali saggi di Bachtin e di Eliot, precisamente, Barenghi abbia in mente. Personalmente, ho sempre pensato che i libri di Bachtin – con le loro fumose genericità, le loro etichette passepartout, i loro mantra scipiti che ancora rimbalzano, per inerzia e acquiescenza al dressage universitario, nelle tesi dei dottorandi: ‘cultura ufficiale’, carnevalesco, polifonia, plurilinguismo, cronotopo – siano un buon esempio di come non bisognava e non bisogna fare storia della letteratura (qualche osservazione più puntuale in un mio saggio di qualche anno fa, Generi non letterari e poesia delle origini, in Codici. Saggi sulla letteratura del Medioevo, Il Mulino 2005). Quanto al metodo-Eliot, se preso al suo peggio (perché c’è anche un meglio, certo da non «buttare a mare»), mi pare abbastanza calzante la descrizione-pastiche che ne ha fatto Edmund Wilson (del quale invece penso tutto il bene possibile) nel Castello di Axel:
T.S. Eliot […] è spesso incline a perdersi in un gioco letterario di scatole cinesi. «Occasionalmente», scriverà, «ritroviamo questa qualità in Wordsworth, ma si tratta di una qualità che Wordsworth ha in comune con Shenstone piuttosto che con Collins e Gray. E per un’esatta valutazione dell’opera di Shenstone dobbiamo leggere sia le sue prose che le sue poesie. I suoi Saggi su uomini e costumi appartengono alla tradizione dei grandi aforisti francesi del Seicento e dovrebbero essere letti con la piena consapevolezza del rapporto che li lega a Vauvenargues, La Rochefoucauld e (pur nella misura più alta) a La Bruyère. Faremo bene, d’altronde, a leggere quel tanto di Teofrasto che ci permetta di comprendere il genere di effetto cui mirava La Bruyère […]». Di questo passo (benché io abbia fatto la parodia di Eliot) dovremmo leggere le opere di tutta la letteratura per apprezzare un solo libro, senza che Eliot ci abbia rivelato il perché di tale sforzo.
Ma le scatole cinesi di Eliot, con le loro genealogie evanescenti, sono comunque meglio, sono cioè meno infondate, delle scorribande nel tempo di Calvino, degli «accostamenti» tra Ovidio e Montale, Flaubert e Giordano Bruno, col «carico di suggestioni» (sempre parole di Calvino) che a questi improbabili accostamenti tiene dietro.
Come molti lettori di Calvino che hanno reagito con irritazione al mio saggio, Barenghi la pensa diversamente, com’è suo diritto, ma non si capacita che io la pensi diversamente: «In verità l’intero saggio di Giunta si direbbe pervaso, anzi, alimentato da un’insofferenza per un autore e un’opera troppo celebrati». Ma non è così, non ho alcuna insofferenza né per la persona né per l’opera di Calvino: è solo che trovo brutte le Lezioni americane (per ragioni, come spero di aver chiarito, di sostanza, e non perché la «superciliosa erudizione» del filologo che sono non tollererebbe inesattezze e sciatterie: tollero entrambe), e deprimente il successo che hanno avuto tra i lettori e tra i critici. Ed è stato ed è soprattutto questo successo a rendermi insofferente, questo coro di ammirato stupore che è risuonato non solo tra i giornalisti come Scalfari ma anche tra quelli che alla fine del mio intervento chiamavo «lettori maturi», un coro che ha fatto delle Lezioni americane il saggio sulla letteratura più letto in Italia nell’ultimo mezzo secolo.
E che colpa ne ha Calvino? Nessuna. L’unico torto di Calvino è stato quello di morire in un’incipiente società dello spettacolo che per funzionare macina, insieme a infinite altre cose, anche i miti culturali: il mito del grande scrittore morente, il mito del grande scrittore che muore dettando il suo Testamento Spirituale, il mito dell’opera incompiuta che fissa, in una visione, lo Zeitgeist non del prossimo decennio, o del prossimo secolo, ma – con caratteristico understatement – del prossimo millennio. È chiaro che Calvino non ha colpe.
Colpevoli sono gli zelanti sacerdoti del mito, e quei lettori che hanno scambiato per un grande saggio quelle che sono delle brillanti e inattendibili note sulla letteratura, note che hanno aperto la strada a uno stuolo di imitatori ovviamente molto peggiori dell’originale, e che per la loro parte hanno contribuito a coonestare alcuni dei tratti che io trovo più ciarlataneschi e puerili nella critica letteraria contemporanea, quella accademica in ispecie: la tendenza a fare peregrini, insignificanti ‘collegamenti’ tra testi delle epoche e delle qualità più disparate; la tendenza a mascherare la propria insicurezza dietro una cortina di citazioni estratte da una specie di patetica Internazionale della critica e della filosofia; l’argomentazione scorciata, allusiva, che evoca anziché spiegare; l’approssimazione nell’uso dei concetti; e, su tutto, su tutto, quel vizio di retorica che porta a prendere i libri, gli scrittori e soprattutto se stessi e le proprie idee molto più sul serio di quanto il buon senso e il buon gusto suggerirebbero. Non è stato un buon esempio, non ha dato buoni frutti.