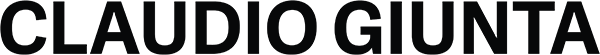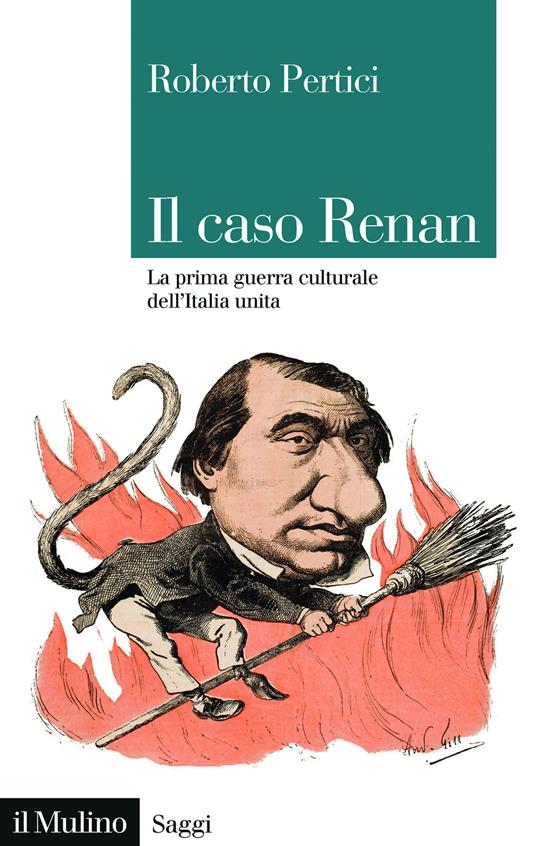Una storia delle idee innervata di fatti. Potrebbe essere questa la formula che descrive la storiografia di Roberto Pertici. Nei suoi ultimi volumi (La cultura storica dell’Italia unita, È inutile avere ragione e Dall’Ottocento alla ‘Dopostoria’) aveva ricostruito per saggi momenti della storia intellettuale del Novecento; ora, con Il caso Renan, ci porta più indietro, agli anni Sessanta dell’Ottocento, quando la pubblicazione in Francia e la traduzione in Italia e nel resto dell’Europa della Vita di Gesù di Ernest Renans provoca un’ondata di reazioni da parte cattolica e di contro-reazioni da parte degli intellettuali laici.
Era un’epoca in cui i libri venivano presi sul serio, e quelli sulla religione cristiana potevano ancora suscitare odi, scomuniche. Ma il libro di Renan fu qualcosa di diverso. Pubblicato nel 1863, venne letto da pochi nell’originale francese, da molti e poi da moltissimi nelle traduzioni italiane: al plurale, perché ve ne furono subito di parziali, su rivista, quindi una integrale a cura del garibaldino Filippo De Boni. Come documenta Pertici attraverso un impressionante lavoro di scavo in biblioteca e in archivio, una valida mano alla diffusione delle idee di Renan la diedero proprio i cattolici, che del libro, contro il libro, presero a scrivere quasi quotidianamente sui bollettini, sulle riviste, e con tanta più foga quanto più gli argomenti di Renan sembravano far presa sull’opinione pubblica, ben oltre la cerchia dei laici dotti.
Nella Vita, Renan non negava né la realtà storica né la grandezza di Cristo, né la bontà della sua dottrina (si tratta, così suona la prima frase del libro, dell’«avvenimento capitale della storia del mondo»); ne negava però la natura divina, il che ovviamente comportava l’inconsistenza e la fine della fede cristiana. Occorreva reagire. Cancellare il libro, come si direbbe oggi (e all’oggi si pensa di continuo, riflettendo sui modi in cui circolavano e circolano le idee), non era possibile, perché il controllo ecclesiastico sulla stampa non era più quel pieno, incondizionato controllo che la Chiesa aveva esercitato nei secoli precedenti, e perché la reazione del potere temporale era stata meno severa e meno tempestiva di quanto la Chiesa auspicasse (Renan fu privato della cattedra di ebraico al Collège de France nella primavera del 1864, quando il libro veniva ormai letto e contraddetto dappertutto). Allora lo si confutò, e nell’opera di confutazione si distinsero periodici come «La Civiltà Cattolica» e «L’Armonia» di padre Giacomo Margotti.
Ma invano. I controversisti cattolici erano abituati a disputare sugli articoli di fede con i propri pari; ma il veleno-Renan era penetrato più a fondo e più largamente tra il popolo, un po’ come, in quegli stessi anni, vi stava penetrando la pubblicista anarchica e socialista. Da questo punto di vista, il libro di Pertici è una miniera di ‘casi’ interessantissimi, e che danno la misura del fenomeno. Ecco per esempio la scena di cui Giulio Carcano dice d’essere stato testimone: un operaio che in una pausa del lavoro, senza degnare di uno sguardo il figlioletto, è tutto assorbito dal «moderno racconto di una storia divina», ossia la Vita di Renan. Questo incontro ispira a Carcano un poemetto intitolato Il libro di Dio, che dedica a Manzoni, e che argomenta come l’esito della miscredenza insufflata da Renan nella menti semplice del popolo non possa che essere il socialismo, la rivoluzione: rinnegata la fede, «ei [l’operaio] più non vive / che per odio e per fame; e vuole un giorno, / un giorno di trionfo!». Oppure: ecco gli affreschi, oggi distrutti, che il parroco di Camposampietro, diocesi di Treviso, commissiona al friulano Rocco Pittaco, il quale sotto l’immagine della Chiesa trionfante dipinge «busti e nomi di eretici, scismatici, protestanti: Azio, Fozio, Calvino, Lutero e cento altri settari», e tra loro e sopra di loro l’eretico Renan, «incarnazione di tutti gli errori passati». Ci si domanda che cosa ci avranno capito i fedeli.
Due cose, tra le altre, stupiscono del Caso Renan. La prima è la rapidità e la forza con cui si diffuse l’incendio. Abituati al ‘tempo reale’ del web, fatichiamo a capire quanto lungo e accidentato fosse il cammino delle informazioni, e più ancora delle idee, alla metà dell’Ottocento. Ma non in questo caso. Lo scandalo della Vie de Jesus scoppiò nel giugno del 1863, anche se era nell’aria da mesi, e in meno di due anni ne scrissero tutti, in mezzo mondo: alla fine del suo saggio, Pertici pubblica una Bibliografia sommaria della polemica antirenaniana in Italia 1863-1865 che fra traduzioni, recensioni e confutazioni conta una settantina di titoli. Incendio rapido, ma non effimero: se, come documenta Pertici, il riferimento – polemico o solidale – all’opera di Renan sarà una costante dei molti scritti su Gesù e sul Vangelo che, nel suo solco, verranno scritti nei decenni successivi.
La seconda cosa che stupisce è, appunto, la quantità e la qualità degli interventi. Non tutti saranno interessati alle vicende del cristianesimo europeo nel terzo quarto dell’Ottocento. Ma facendo la storia della ricezione della Vita di Gesù Pertici fa la storia dell’Italia postunitaria secondo un’ottica originale, nella quale hanno una parte di rilievo non solo le ‘figure prime’ della cultura italiana, come Manzoni e Tommaseo, ma anche una gran quantità di scrittori e studiosi poco o per nulla noti, e che Pertici ritrae con una perizia e – cosa ancora più ammirevole – con una pietas che allo studioso di letteratura fanno venire certe pagine ottocentesche di Timpanaro (ma senza i suoi spigoli) o di Dionisotti. Mi pare sia un libro da cui s’impara moltissimo, e in molte direzioni, e che è destinato a produrre altri libri.
Roberto Pertici, Il caso Renan. La prima guerra culturale dell’Italia unita, Il Mulino 2025.