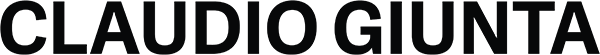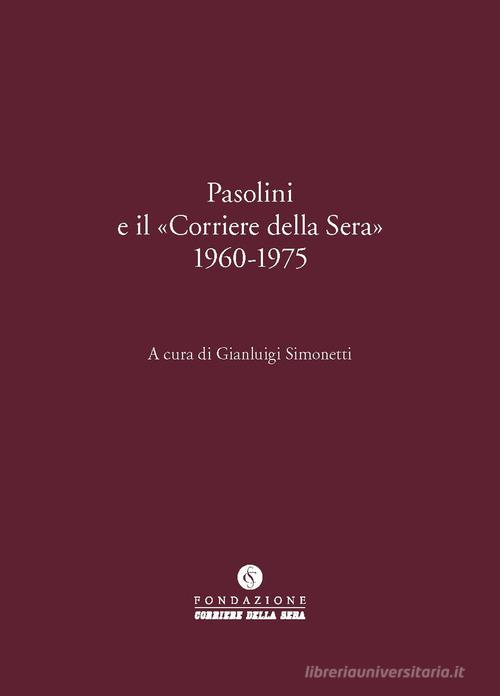Per il cinquantenario della morte, Gianluigi Simonetti ha curato per la Fondazione Corriere della Sera un volume dal titolo Pasolini e il «Corriere della Sera» 1960-1975 che raccoglie gli articoli pubblicati dallo scrittore su questo giornale soprattutto a partire dalla direzione di Piero Ottone.
Non c’è già tutto nelle due raccolte Scritti corsari e Lettere luterane? In realtà no: mancano, a parte pochi scritti occasionali anteriori al gennaio 1973, alcuni articoli tematicamente eterogenei rispetto al tema-guida di quei due libri (politica e società), e soprattutto manca l’inedito Quiz, che Simonetti ha trovato nell’Archivio Storico del Corriere della Sera, e che da solo vale – diciamo – il prezzo del volume (Pasolini insolentisce un ignoto scrittore del quale invita il lettore a scoprire il nome: in premio, una copia di Thalassa di Sándor Ferenczi e una caricatura del suddetto scrittore «con la coda da sirena»). Ma il valore del libro sta soprattutto nell’introduzione di Simonetti, che è, come sempre, un modello di intelligenza e di nitore, e in una cinquantina di pagine fa varie cose interessanti: ricostruisce la carriera giornalistica di Pasolini sin dagli anni della giovinezza; informa esaurientemente sulla collaborazione al «Corriere»; inquadra le pagine del Pasolini giornalista nel complesso della sua opera, e sullo sfondo della vita italiana dell’epoca. Molto ci sarebbe da citare, ma bastino queste poche righe in cui Simonetti coglie perfettamente la cifra del Pasolini ‘corsaro’ nell’incontro tra osservazione oggettiva, da etnografo, e autobiografia: «Il più profondo paradosso di questo giornalismo consiste allora nel fatto che lo studio di una trasformazione collettiva, di carattere antropologico e politico [vale a dire la mutazione, il genocidio perpetrato dal miracolo economico], muove da un’esperienza riservata, intima, di carattere sentimentale e sessuale. Le accomuna la drammaticità con cui l’una e l’altra vengono vissute da questo intellettuale costantemente attratto dalla figura del ‘doppio’, e adesso disposto a rappresentarsi esplicitamente come un dottor Jekyll e Mister Hyde».
A libro chiuso, viene da riflettere, più ancora che sulla stagione del Pasolini ‘corsaro’, sulla sua ricezione nel corso di questi cinque decenni. Si sa: non c’è autore contemporaneo che più di lui si confonda col suo mito; e non c’è autore contemporaneo su cui gravi una nebulosa di parole d’ordine altrettanto densa, così densa da aver reso quasi invisibili i libri in cui quelle parole sono state dette e ripetute. Anche per colpa di ammiratori scriteriati, ci si trova di fronte un santino, un meme (e ne è venuto, per reazione, il vezzo opposto: di sminuire scioccamente l’opera di un grande narratore e poeta, e di un saggista sommo).
Proiettata in aula agli studenti di Lettere del primo anno, l’intervista-monologo di Pasolini sulla costa laziale, con Sabaudia sullo sfondo («… È stato uno specie di incubo in cui abbiamo visto l’Italia intorno a noi distruggersi e sparire, e adesso risvegliandosi forse da quest’incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c’è più niente da fare»), ha un successo sorprendente, indigna, commuove. O forse non c’è niente di cui sorprendersi: la giovinezza è l’età del lamento e della recriminazione, e tende ad essere sedotta da chi maledice (con un’elocutio così efficace, poi!), mentre diffida dei benedicenti, perché del mondo tende a vedere soprattutto i guasti, le lacune. Ma certo fa riflettere questa solidarietà tra uno scrittore nato nel 1922 e una classe di ragazzi nati dopo il 2005, tra un uomo che è cresciuto tra la Bologna del primo dopoguerra e la campagna friulana, e una generazione che abita quello che lui stesso presagiva (più a torto che a ragione) come «un mondo inespressivo, senza particolarismi e diversità di culture, perfettamente omologato».
Gli intellettuali nati nei primi decenni del Novecento hanno visto le cose intorno a sé – il paesaggio, i costumi, i corpi – cambiare in una misura e con una rapidità tali da non avere eguali nella storia umana: dal mondo contadino a quello delle fabbriche e degli uffici; dalla campagna alle città; dalla produzione per il consumo al consumo posizionale. Sul piano della vita pratica, la modernizzazione ha significato soprattutto l’invenzione di strumenti atti a rendere più comoda, sicura e veloce l’esistenza. Sul piano della vita spirituale, mentale, la modernizzazione ha significato soprattutto conoscenza e consumo di nuove forme di comunicazione, con i riflessi che questo consumo ha avuto sul piano dell’habitus («adeguarsi – sempre Pasolini – nel comportamento, nel vestire, nelle scarpe, nel modo di pettinarsi o di sorridere, nell’agire o nel gestire a ciò che [i giovani] vedono nella pubblicità, poniamo in quella della TV») e del linguaggio («a Roma, per esempio, non si è più capaci di inventare, si è caduti in una specie di nevrosi afasica; o si parla di una lingua fiorita, che non conosce difficoltà e resistenze, ci si esprime come nei libri stampati»).
Come vietare a coloro che accedono alla modernità la loro dose di automobili, telefoni, elettrodomestici, case nuove? Ma anche: come impedire che questa trasformazione così repentina nelle forme della vita distrugga l’ambiente nel quale essa si è svolta sino ad ora, e corrompa le anime dei suoi abitanti? Agli intellettuali del pieno Novecento questo dilemma ha suggerito soprattutto lamenti sull’approssimarsi di una nuova barbarie, anatemi: sicché alle nostalgie di Pasolini per quel «paese meraviglioso [che] era l’Italia durante il periodo del fascismo e subito dopo», quando si poteva ancora credere che «quella meravigliosa cosa che era la forma della vita non sarebbe cambiata», sarebbe facile affiancare le analoghe nostalgie di suoi contemporanei dall’indole e dall’orientamento politico anche molto diversi: Camporesi, Zolla, don Milani; e fuori d’Italia Illich, Lasch.
Ma naturalmente nessuno, come Pasolini, ha saputo trasformare questa nostalgia per il mondo di ieri in mito.
A differenza di altri intellettuali attivi in quegli anni, non pensava che la medicina per i mali del mondo andasse cercata in Unione Sovietica, o in Cina, o a Cuba. Non è rimasto immune dall’infatuazione per lo spontaneismo dei ribelli (ciò che lo affascina nella Lettera a una professoressa è, scrive, «la stessa forza ideale, assoluta, totale, senza compromessi» che si trova «nella nuova sinistra americana, e specificamente newyorchese, o, dall’altra parte dell’orbe terracqueo, nella rivoluzione culturale cinese»), ma non è stato un ‘pellegrino politico’ di quella risma.
Nel presente, era attratto da tutto ciò che, fuori dai confini dell’Europa, resisteva, ignorandola, alla tempesta della modernizzazione. Perciò non i Paesi del socialismo reale ma l’Africa, lo Yemen, l’India rurale in cui tutto è «lindo e puro», e dove ben più esiziale della miseria sarebbe, per questo popolo che si affaccia alla storia, «l’esperienza borghese, che finirebbe col diventare di tipo balcanico, spagnolo o borbonico». E Isfahan, piena di ragazzi come se ne vedevano un tempo in Italia: «dignitosi e umili, con le loro belle nuche, le loro belle facce limpide sotto i fieri ciuffi innocenti» (ma tra loro, all’improvviso, ecco «due esseri mostruosi», due ‘capelloni’ conciati secondo la moda della contestazione europea che silenziosamente dicono: «ecco qui i nostri capelli lunghi che testimoniano la nostra modernità internazionale di privilegiati!»). Oppure, entro i confini europei, vagheggiava l’idea di una Napoli fantasmatica, ossia del popolo napoletano «nei suoi vichi, nelle sue piazzette nere o rosa», che rifiuta di entrare nella storia: «La stessa cosa – osservava – fanno nel deserto i Tuareg o nella savana i Beja (o fanno anche, da secoli, gli zingari): è un rifiuto, sorto dal cuore della collettività». Anche la sua smania di giovinezza era il rimpianto per un’età aurorale, non ancora intaccata dalla consapevolezza che viene dall’esperienza e dalla cultura, e insomma dal vivere: «I ragazzi e i giovani sono in generale degli esseri adorabili, pieni di quella sostanza vergine dell’uomo che è la speranza, la buona volontà: mentre gli adulti sono in generale degli imbecilli, resi vili e ipocriti (alienati) dalle istituzioni sociali, in cui crescendo, sono venuti a poco a poco incastrandosi». Gli adulti, di solito, pensano il contrario.
Ma dal momento che questa resistenza al cambiamento poteva darsi ormai soltanto nelle periferie del mondo, o in certe enclave più immaginarie che reali, ecco soccorrere il mito del passato come «era della pietà» contrapposta all’«era dell’edonè», ecco soprattutto l’elogio dell’inazione, della stasi, della silenziosa resistenza dei subalterni al dominio dell’aristocrazia prima e della borghesia poi: «ci sono – scrive parlando degli anni del fascismo – intere epoche, anzi millenni, della storia umana, in cui il popolo è stato così».
In questa nostalgia per l’immobilità del mondo pre-consumistico o pre-industriale non c’è niente che possa essere etichettato come ‘di destra’ o ‘di sinistra’; c’è invece il desiderio di vivere una vita semplice, non scossa da traumi o cesure, all’interno di un paesaggio il più possibile simile a quello nel quale si è nati. È un desiderio molto umano, ed è soprattutto per questo – per l’eloquenza con cui ha saputo dargli voce – che Pasolini, specie il Pasolini degli ultimi anni, è oggi uno scrittore anzi un uomo conteso, amato da quasi tutti. Quasi. Perché chi ha – in breve – una concezione liberale dell’esistenza non può non ricordare che è umano anche l’opposto desiderio di uscire dalla stasi, di approfittare della tempesta della modernità per dare a sé e agli altri la possibilità di diventare qualcosa di diverso da ciò che l’inerzia del passato impone di essere. Gli intellettuali, di solito, e Pasolini più di tutti, sono conservatori per gli altri. Uscendo da un atroce mall di Dubai, George Saunders riflette: «Mi viene in mente che l’uomo è una gioiosa macchina che vende e compra. Ho sbagliato, ho sbagliato di grosso a condannare il consumismo. Il consumismo è connaturato nell’uomo. È, in un certo senso, un sacro impulso […]. L’uomo è un essere che desidera migliorare la propria sorte» (La nuova Mecca, in Il megafono spento). Un sacro impulso: migliorare la propria sorte. Certo, è una forma di sacertà opposta rispetto a quella che Pasolini rimpiangeva; e, tra l’altro, infinitamente più volgare (ah, i mostruosi capelloni di Isfahan…). Ma non meno umana.