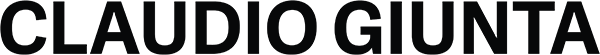Magnificare la lettura dei cataloghi delle biblioteche fa subito emulo inadeguato e un po’ kitsch di Eco, di Borges. Ah, perdersi voluttuosamente in quelle foreste di nomi, di titoli, di marche tipografiche… C’è un più sicuro segno di snobismo?
Ma è un fatto che per chi ama le biblioteche, per chi vorrebbe spenderci i giorni e le notti senza uscirne mai, poche occupazioni sono più piacevoli di questa: non perdersi in mezzo ai nomi e ai titoli ma, al contrario, trovare una via, un principio, comprendere la strategia che l’ha ordinata, e così anche scoprire quali libri si leggevano, quali libri circolavano tra i nostri simili, i topi di biblioteca di epoche e luoghi lontani.
Di solito si tratta appunto di biblioteche antiche, ma non è detto che il passato prossimo sia meno interessante del passato remoto. Il ventesimo secolo è stata l’età delle grandi biblioteche, e il secondo Novecento è stata l’epoca in cui tutte le università si sono dotate di una biblioteca adeguata. Le università storiche partivano avvantaggiate, ovviamente, almeno quanto al numero dei volumi posseduti. Le nuove università hanno dovuto investire, e ovviamente c’è chi lo ha fatto bene e chi no.
L’Università di Trento lo ha fatto benissimo. Oggi dispone di una delle più grandi e belle biblioteche universitarie italiane, la BUC: che oltre a essere grande e bella ha una caratteristica rara, nel panorama italiano, e cioè è una, una sola, laddove spesso le università storiche non hanno saputo o voluto far confluire le biblioteche di dipartimento in un unico luogo, con danno sia per gli studiosi sia per il contribuente, che deve pagare le spese non di una sola grande sede ma di venti piccole sedi decentrate.
A Trento tutto è cominciato alla fine degli anni Cinquanta, quando l’amministrazione provinciale, che dal 1960 sarà guidata dal presidente Bruno Kessler, decise di aprire in città non una succursale della Cattolica dedicata alle Scienze Forestali, come qualcuno aveva proposto, ma quella che sarebbe poi diventata la facoltà di Sociologia, e che nel 1962, quando comincia la sua attività, si chiamava Istituto Universitario di Scienze sociali.
Era il primo istituto di questo genere, era la prima laurea in Sociologia del Paese, bisognava creare una biblioteca, comprare dei libri, sollecitare donazioni. Lo si fece. Come? È la domanda cui risponde questo bel volume, Sociologia 1962-1963, che racconta appunto la genesi di quella biblioteca e, attraverso i libri che vi si trovavano e quelli che non vi si trovavano, restituisce l’immagine della disciplina Sociologia che i fondatori avevano in mente: ciò che essa era e ciò che avrebbe dovuto diventare.
Si tratta perciò di uno di quei libri che vanno consigliati soprattutto agli esperti, e ancora di più a coloro che si avviano a diventarlo: con l’aiuto del saggio introduttivo di Giuseppe Sciortino potranno imparare molto sulla genealogia italiana di questa «scienza inferma, arbitraria e sconclusionata» (è la celebre definizione-invettiva di Croce). Che cosa fecero comprare, gli studiosi che iniziarono a insegnare all’Istituto in quei primi anni Sessanta? Quali libri consideravano fondamentali per la formazione dei pochi e poi dei molti aspiranti sociologi che andarono a studiare a Trento? «Come in buona parte della successiva autocomprensione della disciplina – scrive Sciortino – la sociologia italiana prebellica e molto marginale nel catalogo, praticamente assente». C’è poco di Pareto e di Ferrero, pochissimo di Gini, niente di Ardigò e di Michels. La sociologia italiana disconosce insomma «un passato contaminato dall’eccessiva vicinanza al fascismo per molti, al positivismo e al liberalismo per tutti». Ci sono i cattolici, il che non stupisce, dato che l’Istituto nasce nella cattolicissima Trento: non solo buona parte delle opere di Toniolo ma anche gli scritti politici di Fanfani, Forlani, Moro, e mezzo scaffale di libri di Sturzo. E Marx, naturalmente, e l’intera collana dei «Classici del marxismo» delle Edizioni Rinascita; ma anche vari interessanti antidoti come Breve guida al gergo comunista di R.N. Carew Hunt e I comunisti non hanno vinto di Luigi Barzini junior.
D’altra parte, osserva ancora Sciortino, «non c’e traccia degli scritti dei ‘ricercatori-attivisti’ italiani, che pure negli anni precedenti avevano scritto alcune dei testi di documentazione e denuncia sociale più pregnanti e di maggiore successo editoriale». Mancano, cioè, i saggi-pamphlet di Danilo Dolci, manca Milano, Corea di Alasia e Montaldi, manca Carlo Levi; mancano anche La via del Sud di Musatti e L’inchiesta alla FIAT di Carocci, nonché saggi illuminanti sulla società italiana degli anni Cinquanta come Le parrocchie di Regalpetra di Sciascia o Baroni e contadini di Giovanni Russo, che peraltro escono nella stessa magnifica collana laterziana «Libri del tempo», che i fondatori dell’Istituto sembrano aver acquistato in blocco. Si trattava, osserva Sciortino, di differenziare la sociologia ‘trentina’, quella finalmente universitaria, dall’inchiesta sociale militante e, più in generale, dalle analisi sociali di denuncia […]. Una scelta comprensibile, ma che col senno di poi consente di vedere i motivi di scontro che definiranno dopo qualche anno l’esperienza trentina: la biblioteca predica un tipo di sociologia ‘professionale’ a una popolazione di studenti che si aspetta, almeno in parte, una sociologia come denuncia sociale». Con il che il campo delle osservazioni si amplia, e tocca questioni – di storia delle idee e degli intellettuali – che potranno interessare anche il lettore non esperto della disciplina.
Sociologia 1962-1963. Il primo biennio dell’Istituto universitario di scienze sociali di Trento. Catalogo della Biblioteca, a cura di V. Carrara, M. Malfatti, S. Retrosi, Università di Trento 2025 (scaricabile gratuitamente dal link hdl.handle.net/11572/459772).